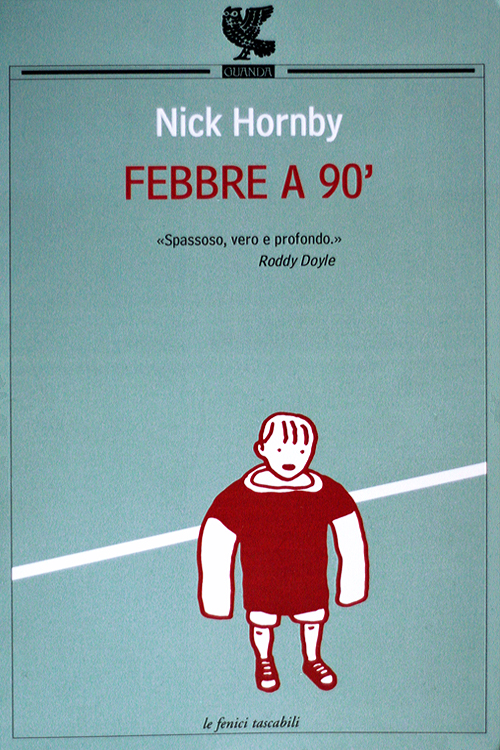“Mi innamorai del calcio come mi sarei innamorato delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente, senza pensareal dolore o allo sconvolgimento che avrebbe portato con sé”. (Nick Hornby).
Fa freddo, un freddo boia. Sono rinchiuso nel soggiorno della mia casetta, una di quelle casette tutte uguali tipiche della perfida albione, una di quelle casette a mattoni, abitata fino a trent’anni fa dalla working class inglese ed oggi residenza di accademici precari e radicali. Una casetta a due piani, con le finestre che si chiudono male, i rubinetti che non possono mescolare acqua calda e fredda, i muri sottili e un giardino da usare due o tre pomeriggi l’anno. Le candele, per fortuna, rendono romantica una serata d’inverno cominciata troppo presto, Baba O’riley risuona in sottofondo, e un the fumante prodotto in qualche sperduta regione indiana mi bruciacchia le dita e il palato a ogni sorso.
E in questo salotto scarno e post-moderno, figlio della fine della civiltà industriale, dove albergano libri, film, un proiettore e poltrone orwelliane, il mio spirito inquieto incontra quello di un’Inghilterra che non esiste più. Un’Inghilterra fatta di fabbrica e sudore, stadi e gradinate di legno; un’Inghilterra dove il calcio andava raramente in televisione.
Aveva proprio ragione Nick Hornby: una persona che perde il senno per una partita di calcio non è un idiota. Anzi. Lo stadio è il simbolo principe di una comunità virtuale e reale, che per qualche ora unisce il disoccupato, il magazziniere, il lavoratore precario, il maresciallo, l’operaio, l’avvocato e persino il professore universitario. Non è un caso che la febbre a novanta sale proprio all’inizo di dicembre. Quando un rapido sguardo al calendario, appeso maldestramente sul muro, mi ricorda che fra poco più di venti giorni gusterò di nuovo quell’abbraccio. Sempre al solito posto, sempre con gli stessi attori.
Sento i commenti dell’improvvisato cronista di novantesimo minuto, scriva subba a schedina ca signau u figliu e Bierhoff, sento zio Gianni che si bea perché mi ha sussurrato in anticipo la sostituzione, sento Roberto che mi indica che il difensore centrale avversario è un tipo tosto, vedo mio padre che fa finta di restare impassibile mentre freme al rintocco dell’ultimo minuto. Il calibro dell’avversario non conta, conta essere lì, per quella partita speciale, che sa di tortellini in brodo e paste da scartare.
Mi sono innamorato del calcio per giornate come questa. Mi sono innamorato all’improvviso, cosi come quando incontri una donna speciale.
I tifosi delle squadre di calcio sono tutti così. Pensano prima di tutto che la loro squadra sia unica e che nessuna, nessuna tifoseria al mondo, possa emulare quelle gesta, quelle trasferte epiche che si perdono nel ricordo e nella leggenda. E poi, ancora più sorprendentemente, pensano che la loro relazione con la squadra di calcio sia unica, inimitabile. Solo loro provano il dolore lancinante di un 4 a 0 devastante, la rabbia per una retrocessione decretata a tavolino, la gioia per una promozione inattesa. Ma è proprio in questo paradosso che si esplica la magia e il valore profetico del gioco, la magia di quella febbre che dura novanta minuti. Una febbre, un’infatuazione, che ci fa sentire unici al plurale.
“Ci sono serate come quella di stasera dove mi sento distrutto dopo aver sudato la maglia per due ore di fila e nel tragitto per tornare a casa penso che nella mia vita il calcio mi ha dato molto. Semplicemente questo, mi ha migliorato come persona a livello esponenziale. E’ proprio difficile spiegarlo ai profani”. È vero, caro Roberto, questa è la magia del gioco, una metafora perpetua della vita, una vita che ricomincia ogni anno, sempre diversa e sempre uguale. Un gioco che ci rende uguali e speciali.
Caro Roberto, vallo a spiegare ai profani.
Emanuele Ferragina